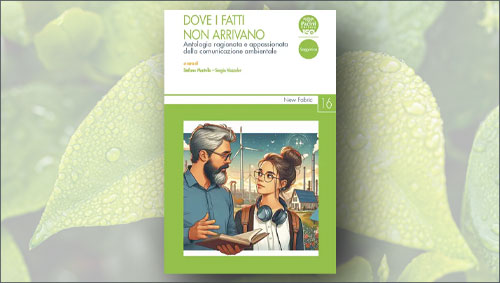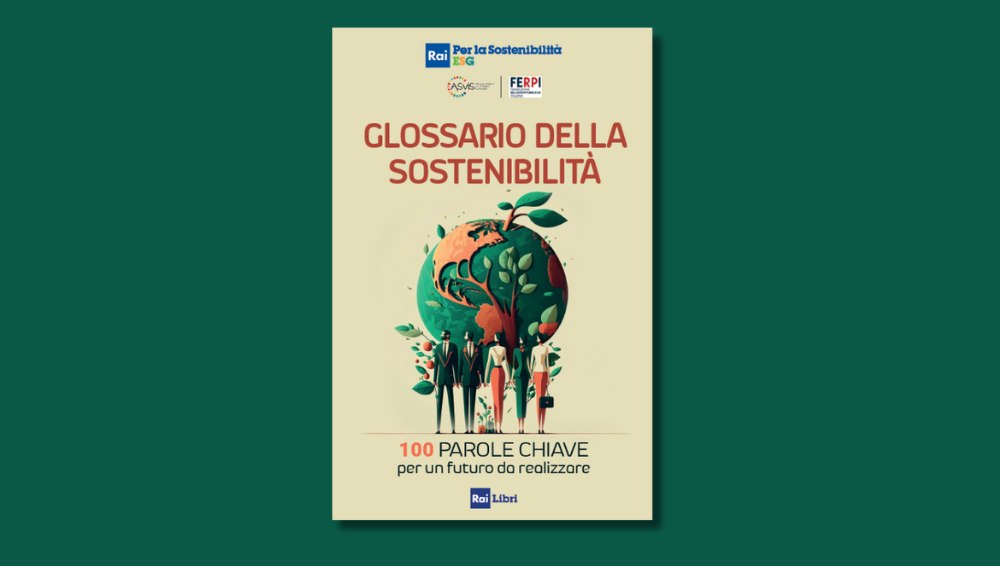La norma “anti-Gandhi”: quando la resistenza pacifica e l’ecoattivismo diventano reato

La criminalizzazione del blocco stradale pacifico e il crescente dibattito sull’ecoattivismo in Italia: a partire dalla norma anti-gandhi tra opposizioni feroci e una riflessione urgente sul nostro futuro e quello del pianeta.
La nuova norma del decreto sicurezza italiano, ribattezzata “anti-Gandhi“, accende una domanda che brucia: cosa succede a un Paese che etichetta come crimine la resistenza pacifica, soprattutto quando si tratta di azioni dell’ecoattivismo? Con questa legge, chi ostruisce la circolazione stradale, anche senza violenza, rischia fino a due anni di carcere. Una misura che, sotto il pretesto della sicurezza, sembra mirare alle fondamenta stesse del dissenso non violento e, nello specifico, al tipo di protesta portata avanti da gruppi come Ultima Generazione. Quei blocchi stradali e quelle manifestazioni, strumenti di disobbedienza civile pacifica che nel passato ci hanno insegnato il valore della protesta, oggi sono trattati alla stregua di reati da sanzionare. Ma è davvero questo il modo migliore di affrontare una crisi climatica di proporzioni globali?
Ecoattivismo e opinione pubblica: un divario profondo
A catalizzare il dibattito sono proprio le azioni forti di movimenti come Ultima Generazione, che ricorrono a blocchi stradali, manifestazioni, e persino atti provocatori come imbrattare opere d’arte per richiamare l’attenzione sulla crisi climatica. Il sondaggio SWG di giugno 2023 evidenzia come queste azioni dividano l’opinione pubblica: la metà degli italiani non condivide tali metodi, mentre il 37% li approva solo in parte, ritenendo che dovrebbero essere meno estremi 18%) e condannando in particolare i gesti contro le opere d’arte (16%). Solo un esiguo 13% sostiene pienamente tali azioni, ritenendole necessarie per scuotere le coscienze di fronte a un’emergenza drammatica.
Questa distanza riflette un trend inquietante: nel dibattito pubblico, le voci critiche – spesso anche aggressive – rimbombano più forti di quelle che, pur dissentendo sui metodi, riconoscono l’urgenza dei problemi e che comunque rappresentano metà dell’opinione pubblica. Così, il messaggio di chi protesta rischia di venire oscurato e ridotto a un semplice problema di ordine pubblico. È possibile che il clamore di queste azioni estreme possa allontanare le persone, rendendo le proteste meno efficaci nel generare il cambiamento che sperano di ispirare. Ma forse l’obiettivo finale di Ultima Generazione e di altri gruppi ecoattivisti non è nemmeno questo: l’obiettivo è portare alla luce il problema, renderlo visibile, anche a costo di attirarsi le critiche. Non sarà piacevole, ma è efficace.
Contestazione come motore del cambiamento (?)
Eppure, anche in questa polarizzazione risiede un fatto innegabile: molte delle conquiste sociali sono nate da manifestazioni provocatorie, anche contestate. I movimenti per i diritti civili, la lotta per il suffragio universale, le battaglie sindacali: tutti hanno usato metodi dirompenti per sfidare il potere e spostare il corso della storia. Certo, ancora una volta si può obiettare che alcune forme di ecoattivismo siano eccessive e rischino di offuscare il messaggio; tuttavia, non si può ignorare il dramma ambientale su cui tentano di portare attenzione.
Il pericolo di un dibattito sterile
Questa “norma anti-Gandhi” e le critiche contro Ultima Generazione mettono a nudo un problema di fondo: la costruzione del dibattito e la sua percezione pubblica. Ridurre al silenzio le voci che urlano il rischio climatico, che sfidano uno status quo incapace di immaginare un futuro sostenibile, mette in luce una incapacità di accogliere la complessità della crisi climatica e delle sue contraddizioni.
Se il futuro umano è in gioco, con che coraggio condanniamo (letteralmente) chi, anche in modo provocatorio, cerca di svegliarci dal nostro torpore? Non è con il rischio del carcere che le profonde motivazioni di queste proteste smetteranno di esistere: saranno solo rese meno visibili. E forse è proprio questo l’obiettivo.